Qualche settimana fa una signora di circa 60 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in pieno centro abitato. Nessuno dei vicini ha saputo dire a quanto tempo prima potesse risalire il decesso, se a qualche settimana o addirittura a qualche mese. Ci avrà pensato forse l’autopsia a stabilirlo. Viveva sola, non andava d’accordo con nessuno, si è detto sulle prime. Era originaria di San Severo. Forse era affetta da qualche disagio psichico, chissà.
In città la notizia non ha fatto granché rumore, sebbene a fine gennaio fosse già successo qualcosa di simile. Un ingegnere, che viveva solo in un appartamento nella zona dei nuovi comparti, era stato trovato morto nel suo letto, a distanza di alcuni giorni dal decesso, avvenuto senza che alcuno se ne accorgesse per tempo. Si è trattato certamente di un malore. Aveva 62 anni.
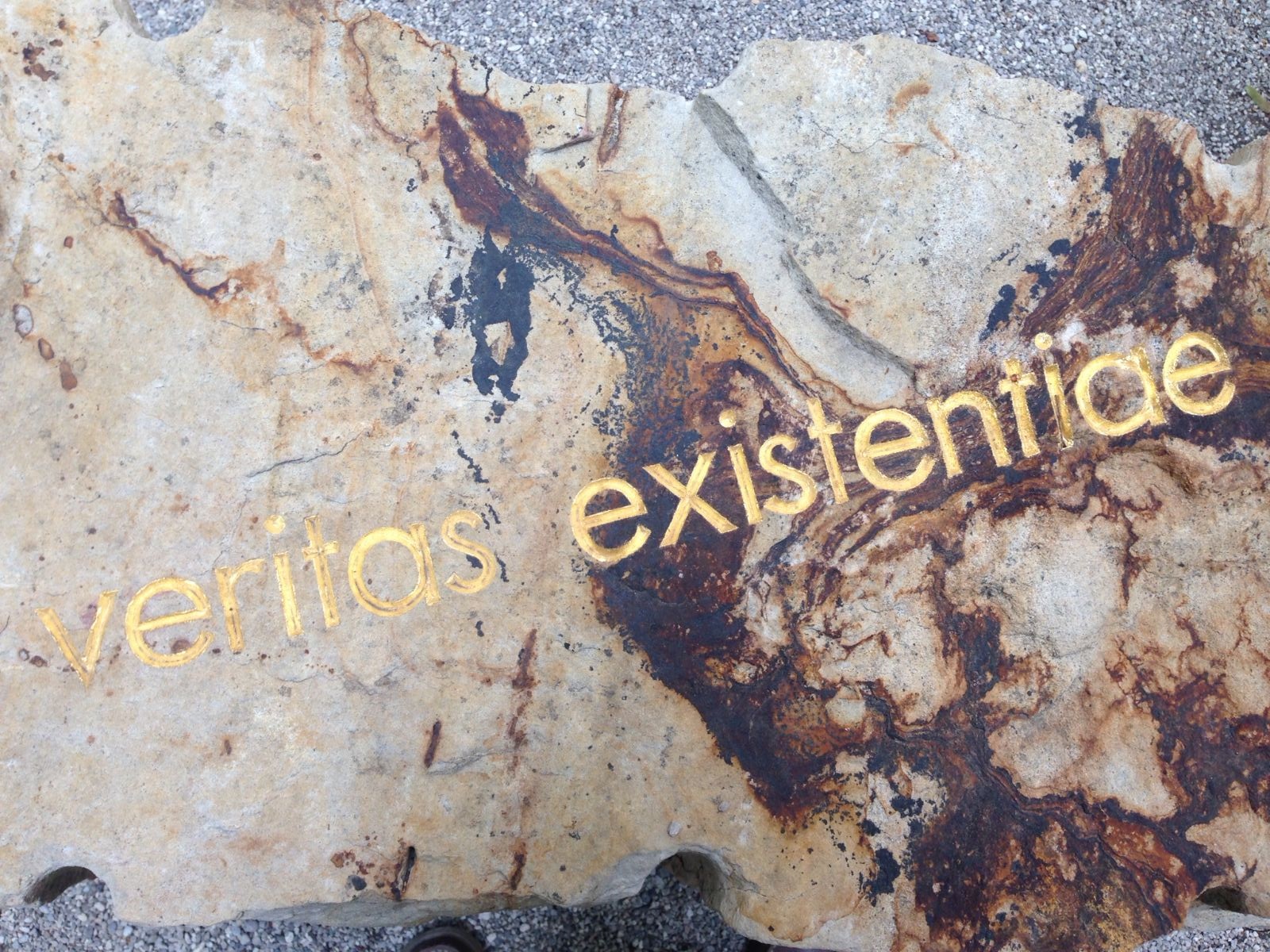 Non c’è da farci nulla. E’ la vita, si è detto. Può succedere.
Non c’è da farci nulla. E’ la vita, si è detto. Può succedere.
Eppure c’è qualcosa che in me resiste a questa rassegnazione. Che mi porta a ritenere che non sia poi così accettabile che tra le nostre case, nel nostro stesso palazzo, una persona possa morire e rimanere così per giorni e settimane intere, sola, senza che nessuno se ne accorga, che chieda di lei.
Sarà che Carlo, l’ingegnere, lo conoscevo da tempo. Solo qualche settimana prima del decesso era venuto da me in studio per un parere. Sarà che aveva solo qualche anno più di me …
Sarà che non si è ancora spenta la polemica tra le forze politiche per la legge da poco approvata, che riconosce a ciascuno il diritto di rifiutare le cure mediche e di far rispettare tale volontà con una sorta di bio-testamento (che la legge chiama DAT- Disposizione Anticipata di Trattamento), nominando, se ritiene, una persona di fiducia che faccia rispettare tale volontà in caso di successiva perdita della capacità di intendere e di volere.
Sarà che negli stessi giorni tutti i mezzi di informazione hanno parlato del processo penale che si è svolto a Milano a carico dell’esponente radicale Marco Cappato, che, dopo per aver aiutato una persona a morire, si è lui stesso autodenunciato per veder affermare in un’aula di giustizia il diritto di ogni individuo a decidere liberamente quando e come morire, con il conseguente dovere dello Stato di consentirne l’esercizio e di garantire la necessaria assistenza.
Andando oltre la tesi difensiva e le stesse richieste del PM (che in buona sostanza affermavano il diritto di morire con dignità “in situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso”), la Corte d’Assise ha rimesso la decisione alla Corte Costituzionale, alla quale ha chiesto di stabilire se non sia più coerente con la Costituzione affermare l’assoluta libertà dell’individuo di decidere quando e come morire, anche a prescindere dalle condizioni di salute e, quindi, non necessariamente in presenza di uno stato di malattia irreversibile.
E’ evidente che la questione, così posta, va anche oltre il tema dell’eutanasia, ossia della “buona morte”, serena e non dolorosa, del morire come alternativa ad una condizione fisica e psichica per non più sopportabile, ed assume i termini del diritto di ciascuno ad autodeterminarsi sulla propria morte come sulla propria vita.
In poche parole, come ha commentato Zagreblesky, si chiede di riconoscere e considerare il suicidio come un diritto, da assicurare in strutture pubbliche o private, e non più, quindi, una tragedia, dettata, come succede il più delle volte, da ragioni di ingiustizia, di depressione o di solitudine.
 E’ così che i due decessi avvenuti a Manfredonia mi hanno fatto tornare alla mente “La solitudine del morente”, il libro del sociologo tedesco Norbert Elias, che già negli anni ‘80 aveva indagato a fondo la condizione di solitudine in cui vive un numero sempre più crescente di persone ed il fenomeno del morire soli.
E’ così che i due decessi avvenuti a Manfredonia mi hanno fatto tornare alla mente “La solitudine del morente”, il libro del sociologo tedesco Norbert Elias, che già negli anni ‘80 aveva indagato a fondo la condizione di solitudine in cui vive un numero sempre più crescente di persone ed il fenomeno del morire soli.
Una solitudine che per Elias non è di natura solo fisica, ma anche affettiva e spirituale.
E non è una caso che sia stato proprio il Regno Unito, il paese che prima di altri in Europa negli anni ’80 con la Thacher ha visto adottare politiche di governo che hanno accentuato tale situazione, a pensare per primo ad un Ministro alla Solitudine, nominato proprio lo scorso gennaio dal Primo Ministro Theresa May, perché si occupi delle persone che ormai a milioni vivono sole, spesso in condizioni di malattia.
In Italia la notizia ha fatto un po’ sorridere, benché questa volta sia meno estemporanea ed eccentrica di quanto non appaia. Gli inglesi hanno compreso forse prima di altri la gravità e la vastità del fenomeno e che occuparsi concretamente della condizione di solitudine di tanti cittadini vuol dire avere un’idea precisa del loro numero, delle loro condizioni di vita e della loro salute, per poter predisporre un adeguato sistema di tutele.
Fortunatamente l’Italia non è l’Inghilterra: da noi, specie al Sud, regge ancora un sistema di relazioni ed uno stato sociale in grado di fronteggiare tale fenomeno, che comunque è in forte aumento.
Non si può però pensare di risolvere il problema della solitudine delegando allo Stato e soprattutto ai comuni ogni iniziativa. Così come non si può pensare che basta continuare a considerare reato l’aiuto al suicidio per riuscire a scoraggiare quanti vogliano farlo. Non c’è ormai legge che tenga, di fronte alla forza di alcune dinamiche sociali.
Occorre piuttosto aiutare le persone ad affrontare la loro condizione di solitudine e di malattia ed a credere che la vita valga la pena di essere vissuta fino in fondo. E questo non può che essere un impegno di tutti, e di ciascuno.
Gaetano Prencipe

No Comment